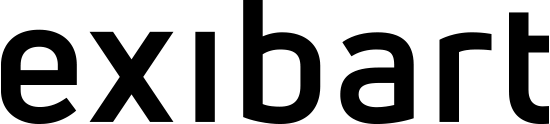-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
“Damnatio Figurae”: una mostra a Padova che rilegge l’immagine del volto
Mostre
Dentro la chiesa sconsacrata di Sant’Agnese il sacro non si è dissolto: ha solo cambiato forma. È stato sospeso, svuotato forse, ma non perduto. E quella sospensione si fa corpo nell’opera permanente di Jannis Kounellis, Senza Titolo (1996): una croce laica altissima trafitta da un pugnale, senza crocifisso eppure più crudele di qualunque icona. Non è un vuoto da colmare, ma da accettare, non un’assenza, ma una condanna.
Da questo squarcio parte la mostra Damnatio Figurae, curata dal direttore Marco Trevisan per la Fondazione Alberto Peruzzo. Non si tratta semplicemente di un’esposizione sulla figura o sull’iconoclastia, ma di un percorso che lavora per negazione, sottrazione ed evocazione. Il titolo latino richiama la damnatio memoriae antica, ma qui viene ribaltata. Non si cancella il nome, si cancella il volto, e nel cancellarlo si mostra ciò che resta: voce, gesto, ferita, identità.

Il percorso si articola tra la navata e la sacrestia, in un dialogo che mette in tensione opere provenienti dalla Collezione Peruzzo con lavori in prestito. Il curatore organizza un rituale laico in cui ogni opera è chiamata a una confessione muta, una verità che emerge solo quando il volto scompare. Le luci basse, tagliate, caravaggesche e chirurgiche al tempo stesso, contribuiscono a isolare ogni opera come in un confessionale individuale, dove non si assolvono peccati ma si rivelano identità spezzate.
Lungo la navata, Aron Demetz, Nicola Samorì, Thorsten Brinkmann e Mariano Sardón lavorano sul volto come superficie da bruciare, da deformare, da frammentare o da digitalizzare. Demetz lavora il legno e il bronzo come se ne cercasse il respiro. Brucia, scarnifica, poi solleva. La figura emerge come residuo di un incendio, come ciò che resta quando tutto il superfluo è stato consumato. Samorì sfregia la pittura barocca come a volerla strappare dal torpore dell’armonia, dalla bellezza che anestetizza. Il suo gesto ferisce, ma solo per riattivare la materia. Brinkmann, con le sue rielaborazioni ironiche del ritratto, costruisce identità eccentriche e intermittenti, mentre Sardón non rappresenta un volto intenzionalmente, ma lo lascia accadere. L’opera si costruisce nel nostro sguardo, non sul soggetto. Il ritratto diventa così esperienza ottica, movimento, interfaccia.

Se la navata sottrae, la sacrestia risponde con figure che ritornano, ma non intatte. C’è Warhol con la sua Queen Elizabeth II (1985), un ritratto regale diventato poster, icona pop che annulla il soggetto per trasformarlo in pura immagine; la regina rivisitata dallo street artist Endless, più punk che pop, accanto all’opera Andy Warhol (2006) di Enzo Fiore. Si compone così un triangolo di rappresentazioni che mette a confronto l’immagine pubblica, privata e distorta di una stessa figura. Donald Baechler con Kuwana City (1990) riduce il volto a forma e colore, astrazione primitiva che parla d’identità senza più alcun dettaglio. A esplorare invece la figura nella sua interezza sono Tom Wesselman e Felice Casorati, che affrontano il corpo femminile da prospettive opposte: una vibrante di sensualità pop, l’altra chiusa in una severa introspezione.
Tutto qui parla anche nel silenzio. La tela di iuta lavorata da Manolo Valdés incarna la pelle del ritratto; Max Ernst, tra le pieghe del surrealismo, deforma i tratti fino a farne maschera onirica; mentre Mimmo Paladino, Zoran Music, Sandro Chia, Fernando Botero e Julio Larraz innescano una riflessione plurale ma coerente sull’identità come costruzione, esposizione e memoria viva.

E proprio la storia del luogo — la chiesa stessa, la sua stratificazione, i resti romani sottostanti, gli affreschi rimossi e sopravvissuti — si fonde con l’allestimento in un gesto che non tematizza il frammento ma lo abita, dilatando la dimensione entro cui la figura può emergere. Il volto qui non è solo ciò che è rappresentato, è ciò che sopravvive alla rappresentazione.
Il percorso si conclude con l’opera Stadium di Maurizio Cattelan, un calcetto monumentale lungo sette metri. Ventidue giocatori fissati su aste rigide. Niente volti, solo ruoli, corpi-maschera, identità manipolate. Un epilogo asciutto ma eloquente, in quanto quel gioco apparentemente innocente è il nostro teatro sociale, dove l’identità non si rivela ma si recita, dove non siamo più soggetti, ma avatar. Damnatio Figurae è allora una mostra che si articola sulle diverse fasi del tempo: la sparizione, il trauma, il ritorno. È un atto visivo e archeologico al tempo stesso, che invita a scavare, rimuovere, ricostruire. Non urla, ma impone un ascolto. Non mostra un volto, ma interroga il nostro sguardo e ci chiede cosa resta quando l’immagine non ci somiglia più.